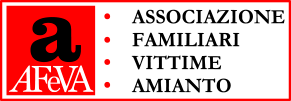Marco Giorcelli è tra le 392 vittime d’amianto nel processo Eternit Bis. E io non sono parte civile

Il 15 marzo 2012 moriva Marco Giorcelli. Il suo ultimo soffio di respiro alle 7 di quel mattino. Per quattordici mesi aveva convissuto con il mesotelioma pleurico o, meglio, con la consapevolezza della malattia conclamata. In realtà, chissà da quanti anni ce l’aveva addosso, ignaro come tutti quelli che ne sono colpiti. Il mesotelioma è il cancro dell’amianto, caratterizzato da lunga latenza rispetto al momento in cui la fibra si è insinuata; silente subdola e paziente, tesse con perfidia la sua tela.
Oggi sono dieci anni esatti dalla sua morte.
Marco Giorcelli, vittima del mesotelioma: aveva 51 anni
Marco Giorcelli non ha mai lavorato all’Eternit, quindi non ha mai maneggiato l’amianto per motivi professionali. E’ stato un ottimo studente al liceo Classico Balbo e si è laureato in Lettere Moderne all’Università di Torino. E’ stato un brillante giornalista da quando aveva diciotto anni e, per diciannove, dall’età di 33 fino alla fine, è stato intelligente e appassionato direttore del bisettimanale «Il Monferrato». Il «suo» giornale.
In via Roma a Casale Monferrato
Marco Giorcelli è morto all’età di 51 anni.
Marco Giorcelli è tra i 392 nomi elencati nel capo di imputazione del processo Eternit Bis, che si svolge in Corte d’Assise a Novara: quel numero – 392 – è un campione (in difetto) delle vittime d’amianto di Casale e dintorni. Sono molte di più.
Marco Giorcelli, appassionato ciclista (2007)
Marco Giorcelli era mio marito.
Ma io non mi sono costituita parte civile.
Perché?
1 – Non ho fatto nessuna transazione per ottenere dall’imputato Stephan Schmidheiny un risarcimento stragiudiziale . E’ una opportunità legittima, che ciascuno sceglie (o ha scelto) liberamente di perseguire o no. In caso affermativo, si rinuncia a costituirsi parte civile. Io no: non ho chiesto e, quindi, neppure ho ricevuto un centesimo.
2 – Un altro motivo per cui non ci si costituisce è che, pur essendo affettivamente e fortemente legati a una vittima, manca un vincolo di parentela che conferisca il diritto a essere parte civile. Io, invece, ne avrei pieno diritto in quanto vedova della vittima.
3 – Un altro motivo per cui si potrebbe decidere di non costituirsi parte civile è per la scarsa fiducia che si arrivi a un pronunciamento definitivo di responsabilità dell’imputato e ai risarcimenti disposti da un giudice: una scarsa fiducia potrebbe essere comprensibilmente motivata anche dalla delusione maturata in molti dopo il maxiprocesso Eternit, che fu spazzato via dalla prescrizione. Ma io no: non ho perso la fiducia che, prima o poi, una sentenza sancisca, in modo inequivocabile, che un torto è stato subito dalla nostra collettività e che qualcuno quel torto l’ha commesso, causando – dolosamente o colposamente lo dirà una Corte – centinaia e centinaia di vittime.
E quindi?
Ho scelto di non costituirmi parte civile perché sono animata da una ostinata e perseverante (si dica pure: anche ingenua) speranza che questa tragedia trovi una possibile pacificazione attraverso un pentimento. E scevra da qualsiasi ricatto di eludere il processo penale.
Ho atteso – fiduciosa, e poi, lo ammetto, frustrata – che l’imputato Stephan Schmidheiny comparisse in aula anche all’ultimo minuto, un attimo prima dei verdetti che si sono susseguiti nel maxiprocesso Eternit a Torino: l’ho atteso il 13 febbraio 2012 all’epilogo del primo grado di giudizio (davanti al monitor del computer, aperto sul tavolo di cucina, in connessione streaming: Marco era già ormai molto debole e io non lo lasciavo solo neppure un istante); e poi il 3 giugno 2013 in Corte d’Appello; e, ancora, il 19 novembre 2014 in Cassazione a Roma. Un imputato ha diritto all’ultima parola. Può scegliere di non sottoporsi a interrogatorio, ma comunque rilasciare spontanee dichiarazioni: e può dire quello che vuole, la propria versione dei fatti, le proprie scuse. Niente. Non si presentò.
Poi è partito il procedimento Eternit Bis, che è stato frazionato in diversi filoni, tra cui quello più consistente che si svolge in Corte d’Assise a Novara, appunto per 392 morti d’amianto a Casale e dintorni.
E io non ho perso la speranza che Schmidheiny si penta.
Sono consapevole di non avere largo seguito in questo mio risoluto obbiettivo e in questo tenace anelito, ma non trovo altra via di pacificazione per questa lunga sofferenza che ha colpito la mia terra e la mia gente.
Io, che anche a scavarmi l’anima e a impuntarmi su ragioni oggettive, non riesco a coltivare il rancore, ho bisogno di un atto di pacificazione. Mi permetto di dire che, stremati dal dolore, ne abbiamo bisogno, tutti.
Per arrivare a questo serve un cambio di passo gigante da parte dell’imprenditore svizzero. Deve uscire dal suo fortino protettivo, dobbiamo guardarci negli occhi.
E potrebbe parlare così: «Io, Stephan Schmidheiny, non volevo uccidere queste persone, ne sono addolorato profondamente, ma non ero totalmente consapevole che l’amianto potesse arrivare a compiere questo stillicidio di morte». Vabbé, bisogna ignorare gli studi scientifici già condotti all’epoca, il convegno di Neuss da lui convocato, i manuali di mistificazione messi a punto e attuati dal suo staff…
Ma andiamo avanti, l’obbiettivo è più alto.
Schmidheiny potrebbe proseguire così: «E’ tuttavia incontestabile che l’amianto l’ho lavorato nelle mie fabbriche, quando, comunque, non era vietato dalla legge». E’ così, anche se dall’imprenditoria del settore non mancarono propaganda e pressioni affinché i Governi (in Italia e altrove) rimanessero a lungo tiepidi o sordi.
Ma andiamo avanti, l’obbiettivo è più alto.
Ancora Schmidheiny: «E’ vero, pur non essendo vietato, io e altri industriali del settore abbiamo ignorato gli allarmati e avvertimenti scientifici (che si sono rivelati fondati) e abbiamo continuato a usarlo fino a che non è stato proibito dalla legge».
E quindi? E adesso? E, quindi, adesso, signor Schmidheiny compia un atto nobile: chieda perdono a tutti noi che abbiamo sofferto e soffriamo. E’ impegnativo, ma indispensabile. E’ il momento per farlo, dopo tanti anni. Per noi, per lei.
E ci aiuti nell’unico modo possibile: investendo le risorse che servono per finanziare la ricerca affinché si trovi in fretta, il più in fretta possibile, una cura. Quante risorse? «Whatever it takes», «Tutto ciò che è necessario».
Non un po’ di milioni buttati lì, «fatene quel che volete, ma lasciatemi stare», no. Serve un organismo – una fondazione o altro – coordinato da lei: come ha dato prova di essere un capace imprenditore (ho sinceramente ammirato il suo impegno per aiutare le popolazioni dell’America latina), se ne metta a capo per individuare e ingaggiare i migliori scienziati nel mondo che, senza liti di bandiera e di vanità (cui con tristezza talora abbiamo assistito!), trovino la terapia risolutiva. Una cura per guarire. Pensi: a Casale Monferrato e nel mondo. Di questo risultato salvifico potrà essere fiero.
Ecco perché non mi costituisco parte civile: perché non perdo la speranza e la limpidezza mentale di mantenere questo canale aperto. Soffro, in quel processo, ma il risarcimento che chiedo a Schmidheiny è molto più di quello che potrebbe riconoscere a me personalmente un giudice.
Nel frattempo, il processo (i processi) fa (faranno) il proprio corso. Questa si chiama giustizia. E i giudici, ne sono certa, ne terranno conto in quello che viene definito «comportamento processuale».
E se Schmidheiny domandasse: «E io che cosa ne guadagno, se tanto il processo prosegue?», questa sarebbe la risposta: «Guadagna sé stesso, signor Schmidheiny, senza la scorciatoia di una contropartita; guadagna la sua pace interiore che, in caso contrario, qualunque siano gli esiti dei processi (quelli in corso e altri che potrebbero essere intentati) non avrà mai, finché vive. E’ la sua grande occasione di riscatto».
Solo a un sincero e fattivo pentimento può seguire un perdono.
Io, parte lesa, attendo il suo passo, con la mente libera e con la mano tesa.
* * *
Quelli che seguono sono due brani per me significativi.
Il primo è l’editoriale che Marco pubblicò, il 31 gennaio 2011, sul giornale che dirigeva dopo che gli fu confermata la diagnosi di mesotelioma. Si intitolava: «Malato d’amianto, ora casalese doc!».
Il secondo è l’ultimo breve capitolo del mio libro «Malapolvere» (Edizioni Sonda) uscito il 10 dicembre 2010. A ispirarmi, nella stesura di quel libro, fu il dolore per la mia gente, di cui ho cominciato a scrivere nel 1984, e non, in quel momento, il caso personale: allora Marco (mentre io scrivevo «Malapolvere») stava benissimo, non c’era nessunissima avvisaglia del male che gli fu invece diagnosticato, sorte malvagia e beffarda, poche settimane dopo. Dopo aver letto la bozza, ignaro del suo imminente destino mi disse: «E’ bello, brava, ma è così doloroso che non lo consiglierei al mio migliore amico».
* * *
MARCO GIORCELLI
Mesotelioma maligno epiteliomorfo. Il verdetto sta lì, in tre parole. Con la terza – mi hanno spiegato – che sa di speranza, perché indica la forma meno aggressiva di questo tumore. Il tumore dell’amianto. Quella che meglio si può provare a combattere, con maggiori speranze di sopravvivenza. E io ci proverò.
Ma quelle tre parole, così nitide su un referto medico che non ha bisogno di aggiungere troppe spiegazioni, da martedì 25 gennaio sono la mia stella di David, il segno di una diversità – chiamiamola malattia – che dentro di me ha cambiato tutto. Fino alla vigilia di Natale, un mese prima, ho lavorato e vissuto a testa bassa: con frenesia, fretta, con la passionaccia benedetta e maledetta di un lavoro che ti tiene incollato in redazione anche 14 ore al giorno. Poi, proprio alla sera della vigilia, una tosse insistente ha fatto suonare il primo campanello. Un’influenza banale, solo un po’ insistente, come quella che va di moda quest’anno? Il prossimo anno sarà meglio fare il vaccino? No, non era influenza. E il vaccino giusto ancora non esiste. Mesotelioma pleurico. È quello che si è portato via prima centinaia di lavoratori dell’Eternit, poi centinaia di cittadini, di età diverse. «Esposizione di tipo ambientale», conclude l’oncologa. Certo. Mica ho lavorato mai l’amianto.
Ma a Casale Monferrato, questa città sfortunata, devastata, che però non posso certo smettere di amare, ci ho vissuto sempre. Cinquant’anni, esclusi appena i periodi ferie, a respirare a pieni polmoni l’aria di questa città che mi ha cresciuto: ad annusare le violette della primavera, a sfidare l’afa dell’estate, a lasciare entrare nelle ossa la nebbia e il fumo delle caldarroste, a mangiare la neve. Studi, amori, amicizie, famiglia, lavoro: tutto qui. A Casale Monferrato e sulle colline intorno: morbide mammelle che ho imparato a conoscere fin da ragazzino, in piedi sulla vespa di papà, che scavallava i bricchi e si fermava a prender fiato sui punti più panoramici, da dove riconoscevamo i campanili, i paesi, il profilo delle Alpi.
Mi sono sempre considerato un casalese doc. Da martedì 25 gennaio, lo sono più che mai. Anch’io porto il segno più profondo della casalesità di questi ultimi cinquant’anni: il tumore dell’amianto. Come migliaia di persone che non ci sono più, come centinaia che combattono la stessa battaglia. Noi di Casale Monferrato. Una piccola Hiroshima, una piccola Nagasaki, una piccola Chernobyl. Ma quanto piccola? Certo siamo compagni di sventura, e se raccogliessimo le tute di coloro che hanno lavorato l’amianto e d’amianto sono morti, ne potremmo fare un cumulo enorme, come ad Auschwitz. E, in un altro mucchio, le scarpe, le borse, i libri di coloro che l’amianto non l’hanno lavorato mai, ma che sono morti ugualmente per questa fibra maledetta.
Finora, dal 25 gennaio, non ho ancora provato rabbia, dico un sentimento personale risentito, per coloro che hanno disseminato la città di quella malapolvere che ha portato via tanti di noi. E tanti amici e persone che ho conosciuto personalmente: Mauro Cavallone, che mi seguiva con la benevolenza di un fratello maggiore, il quale quasi non ha avuto nemmeno il tempo di combattere e che mi ha aspettato per l’ultimo respiro; Luisa Minazzi, che ha tenuto a bada per qualche anno proprio la varietà meno aggressiva, e che forse ha respirato polverino in quel cortile vicino all’argine nel quale giocavo anch’io, da ragazzo: ma saranno passati quasi 45 anni; Giorgio Cozio, che ha sofferto nella stanza accanto alla mia e se ne è andato in silenzio, in una notte; Alessandro Prosio, che un giorno è venuto da me in redazione con un bigliettino con su scritto: «Maledetto amianto. Grazie Eternit» e che qualche mese dopo si è arreso. E tanti, tanti, troppi altri: mio zio Valente, mia zia Anna.
O meglio, vorrei dire, per ora non mi si è aggiunto – forse perché il dolore fisico mi ha finora risparmiato – nessun ulteriore sentimento di rabbia, per il fatto di essermi trovato cucita anch’io, sulla pelle, questa stella di David fatta con una parola, mesotelioma. Perché la rabbia la provo da anni: non per gli imputati del maxiprocesso che si sta celebrando a Torino, il più grande mai aperto in Italia per una strage sul lavoro, ma per tutto quel cumulo di crudeltà, menzogne, sotterfugi, connivenze, che ha consentito ai «signori dell’amianto» di costruire, a Casale e nel mondo, una mostruosa macchina per produrre potere e denaro, denaro e potere: una fuoriserie con piccolo, forse – per loro – trascurabile difetto, quello di consumare carburante umano: dignità, vite e famiglie spezzate. Trasformate in polvere prima che il loro destino fosse compiuto.
Onestamente, prima del maxiprocesso in corso a Torino, pensavo che all’origine del disastro ci fossero atteggiamenti gravemente colpevoli, ma soprattutto irresponsabili: una terribile leggerezza, una tremenda sottovalutazione del rischio. Ciò che è emerso al processo, che ha rilevato l’esistenza addirittura di manuali della menzogna e dunque una atroce consapevolezza di quanto si stava facendo e causando, mi ha atterrito. Dei colpevoli ci sono sicuramente e il loro è stato un delitto contro l’umanità.
Gli imputati hanno diritto a un processo giusto e auguro loro di non essere colpevoli: altrimenti per loro si dovrebbe provare pena, più che rabbia, per come hanno negato il senso dell’umanità nel nome del profitto, del potere. Certo, noi di Casale Monferrato chiediamo giustizia. Per i nostri morti, per le nostre sofferenze, per le nostre famiglie sconquassate come se sul nostro cielo si fosse combattuta, nel ventesimo secolo, un’altra guerra. Lunghissima, estenuante. E senza possibilità di difenderci. Un crimine contro l’umanità.
* * *
Dal libro «Malapolvere» (2010, Edizioni Sonda)
Lettera aperta
Signori dell’amianto, ascoltate.
Noi che l’amianto ci ha marchiato la vita oggi viviamo nella paura. Migliaia di paure individuali che, sommandosi, diventano angoscia collettiva. È straziante il dubbio che, d’un tratto, senza preavviso, tocchi a te o, peggio ancora, a tuo figlio, a tua madre o a tuo padre, a tuo fratello, a tuo marito o a tua moglie, che tocchi al tuo amico, al tuo collega, al tuo vicino di casa essere la prossima vittima del mesotelioma. Più dell’amianto è questo suo figliastro crudele l’ossessione delle nostre giornate, l’incubo delle nostre notti.
Noi che l’amianto ci ha marchiato la vita studiamo, lavoriamo, cresciamo i nostri figli, li guardiamo giocare e vivere, facciamo programmi, accendiamo il mutuo per la casa, investiamo sane ambizioni nel lavoro con il dubbio latente che i nostri progetti futuri possano già essere preda inconsapevole della fibra piccolissima che potrebbe strozzarci il respiro.
Noi che l’amianto ci ha marchiato la vita temiamo i giorni di una sentenza senza appello. Chiunque si sottoponga al giudizio degli uomini ha più occasioni per provare la propria innocenza, per scongiurare una condanna, per appellarsi alla comprensione e alla pietà umana. E chiunque si affidi al giudizio di un Dio sa che la Sua misericordia terrà conto di un sincero pentimento. La fibra di amianto no: non conosce né il senso di giustizia né si china alla pietà. Colpisce senza logica e uccide. Non valgono bontà d’animo, istruzione, censo.
Noi che l’amianto ci ha marchiato la vita vogliamo liberarci dall’inesorabilità di questo nodo scorsoio.
Unico modo possibile: trovare un medicamento vittorioso sul mesotelioma.
Ma servono denari.
Signori dell’amianto, servono i «vostri» denari.
Quanti? Stabilitelo voi. Con l’acume imprenditoriale che vi ha garantito molti successi, fate il migliore e il più nobile degli investimenti: cercate i più capaci scienziati, affidate loro il compito e motivateli «concretamente» verso l’obbiettivo.
Sarà il «nostro» comune obbiettivo: più in fretta i ricercatori troveranno la soluzione efficace e definitiva, più in fretta voi interromperete l’erogazione finanziaria e più in fretta noi celebreremo la vittoria della guarigione sul mal d’amianto.
Sarà, quel giorno, un giorno bellissimo. Per tutti.
Noi che l’amianto ci ha marchiato la vita vogliamo credere che non vi tirerete indietro. Nessun «ingegnere dell’immagine» potrebbe costruirvi un volto migliore di questo. Nessun giudice e nessun aggiustatore di coscienze potrebbe offrirvi un’assoluzione e una redenzione etica più virtuosa.
L’unico modo per farcela è investire in questa battaglia.
L’unico modo per vincere la battaglia è non lasciare il campo prima di aver sconfitto l’avversario.
Sarà così, vero?
Silvana Mossano